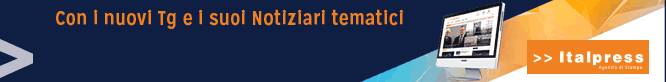Per un turismo che non sia solo consumare

Questa, qui sopra, è una citazione, incompleta e un po’ banale, che tuttavia contiene il senso del turismo, inteso come visita e scoperta (e magari ricerca di conoscenza e di emozioni) e non come mera tintarella.
Se a uno capita di fare l’assessore al turismo, scopre ben presto che i suoi elettori, delle emozioni del visitatore non gliene importa un bel fico secco. Ciò che importa agli elettori è lontano anni luce dal turista, dal visitatore e dalle emozioni che questi signori si aspettano dal viaggio intrapreso, in cui essi hanno investito soldi e da cui attendono un ritorno soddisfacente.
Ovviamente, l’attesa di entrambi i soggetti – l’indigeno e l’alieno – non è sempre massificabile, nel senso che spesso gli abitanti di un luogo non sono tutti ben disposti nei confronti di quello che chiameremo turista, soprattutto se anziché essere un signore (una coppia, una famiglia), è un insieme di tanti, in marcia dietro uno o una dotati di ombrellino, banderuola o altro oggetto atto a farsi agevolmente seguire.
Ma nemmeno gruppi sparsi, seduti sui gradini di un palazzo, alla cerca di ombra, mangiando un triangolone di pizza e bevendosi qualcosa, hanno un effetto tonificante sui nervi di uno che abita in una cosiddetta città d’arte. E diciamolo francamente: il diffondersi di gruppi pulmanati o meno, di invasioni ‘pacifiche’ di studenti, di corpi distesi o stravaccati sulle sacre pietre, sotto i nobili archi, in prossimità degli austeri androni, non piace neppure al turista – viandante colto o ricco viaggiatore, o intellettuale che si rinfresca la conoscenza – che era stato colto “dall’irresistibile desiderio di camminare in quelle strade, calpestare quelle pietre e finire la giornata nel ristorantino delizioso di cui aveva sentito parlare…”.
Perché dopo secoli di promozione gratuita e di testimonial di grande rinomanza, dopo appena pochi decenni di turismo di massa, le città d’arte stramazzano, soffocate dagli odori uniformi di cibo, invase da pletore di gente “che ha pagato per essere lì”, a tutti i costi e per motivi lontanissimi da quelli che hanno originato il mito del luogo in cui sono arrivati.
Perché, dall’altra parte è cresciuta un’economia il cui obiettivo è quello della crescita dei numeri e dei fatturati, a qualsiasi costo, anche a quello della sopravvivenza dei luoghi.
Però quando i luoghi – soprattutto le città “d’arte” – perdono i loro caratteri, le loro bellezze si decompongono, e diventato solo più luoghi per fatturare, per crescere, per fare numeri, per far vendere prodotti, che a loro volta devono produrre numeri (il loro significato non importa), i luoghi si consumano e decadono. Naturalmente qualcuno può pensare che sì magari è vero, però ce ne vuole del tempo, affinché ciò accada, ma io mi affretto a ricordare che oggi le accelerazioni avvengono molto più velocemente di dieci o cinque anni fa, e che – a voler essere mercantili – il concetto di esclusività è quello che vende di più, e solo in apparenza è più impegnativo, nella sostanza è più agilmente trasformabile in una valida strategia per rendere a una città un po’ della suggestione perduta.
Ciò è urgente, ma per non perdere del tutto il capitale di una comunità, e per dare ad essa un inizio di nuova prospettiva per un futuro adeguato all’antica fama, mi permetto – non avendo altro titolo se non la passione e forse un briciolo di buon senso – di consigliare la strada della conoscenza.
Con auguri affettuosi all’assessore al turismo.
Silvana Biasutti